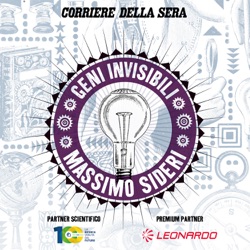Episodes
-
Chi ha inventato i plantoidi? E, soprattutto, a cosa servono? Negli ultimi anni abbiamo scoperto che anche la natura ha una sua forma di intelligenza. E anche di comunicazione sotterranea attraverso i funghi: si chiama «Wood Wide Web». Una forma di intelligenza sviluppata in decine di milioni di anni. Ecco allora come stiamo tentando di sviluppare una tecnologia che ne apprenda i segreti, rispettandone l'equilibrio. In questo podcast ne ho parlato con Barbara Mazzolai, la madrina di queste piante-robot presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Che pensa già a una tecnologia che alla fine del proprio ciclo di vita possa essere riassorbito dall'ecosistema, come avviene con le piante che muoiono. Utile anche, per esempio, per tutti i rover che stiamo spedendo sulla Luna e su Marte. Di questo intreccio di intelligenze (naturale, artificiale, collettiva) ne ho parlato anche con Carlo Ratti, professore all'Mit e al Politecnico di Milano che dirigerà la Biennale dell'Architettura di Venezia nel 2025. Tre intelligenze che dovrebbero unirsi come una triplice elica del Dna per cercare di dare delle risposte a un altro grande malato, la città. Che dovrebbe diventare un plantoide su scala enorme per ripensare se stessa.
-
Quando è stato inventato lo sciopero? Incredibilmente, abbiamo anche una data: il 1155 avanti Cristo, durante il regno di Ramesses III. La fonte è un papiro residente proprio nel Museo egizio di Torino detto “papiro dello sciopero”. Lo conferma l'ospite del podcast Christian Greco, egittologo di fama e direttore del Museo egizio più antico del mondo: «Non ricevendo la paga da due mesi gli operai della necropoli che vivevano a Deir el-Medina si rifiutarono di lavorare. Lasciarono la necropoli e incrociarono le braccia. Lo possiamo considerare a tutti gli effetti uno sciopero». Conosciamo anche l’autore del papiro dello sciopero: lo scriba Amunnakh. Il documento entrò nella collezione dopo essere stato acquistato da Bernardino Drovetti nel 1824 a Tebe, l’attuale Luxor. Meraviglia della conoscenza. Altro che ChatGPT. Le informazioni sono come un ago nel pagliaio e l’unico modo per scovare quelle che ci servono è studiare. Poi lo studio e la conoscenza possono rendere l’Ai uno strumento formidabile. Ma cosa ne rimane oggi? Ne ho parlato con Marco Bentivogli, attivista, ex sindacalista ed esperto di politiche del lavoro, con cui ricostruiamo la storia di un diritto messo sempre più alle strette dalla parcellizzazione dell'economia causata dagli algoritmi.
-
Missing episodes?
-
In una serie di conferenze internazionali, raccolte poi nel saggio Una pietra sopra con il titolo di Cibernetica e fantasmi, Italo Calvino parlava dell’arrivo futuro di “una machina scrivente, in cui sia stata immessa un’istruzione confacente al caso, (che) potrà elaborare sulla pagina una personalità di scrittore spiccata e inconfondibile, oppure potrà essere regolata in modo di evolvere o cambiare personalità a ogni opera che compone”. Erano gli anni Sessanta. Oggi a quella macchina abbiamo dato il nome di ChatGPT. Al di là di qualunque valutazione sulle effettive capacità dell’intelligenza artificiale generativa, rimane sospesa una domanda: come fece Italo Calvino, un romanziere - un premio Nobel mancato per la letteratura - ad anticipare una delle più straordinarie evoluzioni tecnologiche 60 anni prima della sua esplosione commerciale? E’ questo l’interrogativo dal quale parto con Andrea Prencipe, rettore della Luiss, in questo episodio di “Geni Invisibili”: come fece Calvino a sognare ChatGPT? Figlio di un agronomo e di una biologa, lo scrittore di Sanremo (come amava definirsi, pur essendo nato a Cuba) scherzò per tutta la vita sul suo essere la “pecora nera” della propria famiglia, un umanista. Eppure per tutta la vita subì la forza gravitazionale della scienza, su cui si manteneva costantemente aggiornato grazie agli abbonamenti alle riviste americane. Curiosità di cui c’è traccia esplicita anche nelle sue famose Lezioni americane in cui l’Università di Harvard gli aveva chiesto di “anticipare” il futuro. Il titolo, non a caso, era: Six memos for the next millenium. Ecco come immaginò quella macchina scrivente il nostro “contemporaneo del futuro”.
-
In via Panisperna a Roma si rimane bloccati da un cancello: qui nel 1934, esattamente 90 anni fa, veniva scoperto da Enrico Fermi e dai ragazzi di via Panisperna - Ettore Majorana, Edoardo Amaldi, Bruno Pontecorvo ed Emilio Segré - il neutrone lento, uno dei passaggi fondamentali che avrebbero portato poi lo stesso Fermi prima a vincere il Nobel per la Fisica e poi a controllare la reazione a catena, alla base sia della bomba atomica americana sia dell’energia nucleare civile. La porta in via Panisperna è ormai chiusa anche se con una procedura burocratica e lenta si può visitare (un giorno al mese) il museo Fermi. L’oblio di questo cancello è la metafora stessa dell’oblio sull’operato di Fermi, riflesso anche nella scarsa attenzione data al nostro fisico da parte di Christopher Nolan, il regista di Oppenheimer. Come mai continuiamo a dimenticarci anche dei nostri geni più visibili? Ne parlo qui con la fisica e divulgatrice Gabriella Greison che ricorda anche un aneddoto formidabile. Quando in un gioco chiesero allo stesso Robert Oppenheimer chi avrebbe voluto essere, diventò improvvisamente serio. E risposte: avrei voluto essere Enrico Fermi. E quando John Fitzgerald Kennedy pensò di riabilitarlo dopo le accuse di essere un comunista firmò per consegnarci la medaglia Fermi. Anche se non riuscì mai a dargliela, in realtà: il presidente americano sarà assassinato poco dopo. Nel podcast si potrà sentire la voce di Fermi grazie alla gentile concessione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma.
-
Chi sono i Geni Invisibili? Inventori, innovatori, grandi scienziati italiani che hanno cambiato la nostra vita come abbiamo scoperto con le prime due serie di questo podcast che sono state scaricate e ascoltate oltre 300 mila volte. Abbiamo così testimoniato che sono italiani il microprocessore (Federico Faggin), la matita (i coniugi Bernacotti), le biotecnologie (Claudio Bordignon), il pianoforte e la dimostrazione dell’esistenza del vuoto (Bartolomeo Cristofori ed Evangelista Torricelli). Ancora: lo sapevate che anche il libro tascabile e il corsivo sono italiani? Così come gli occhiali, la chiocciola, il telescopio galileiano. Passato, presente e futuro del progresso. Ma non finisce qui perché il nostro viaggio continua tutti i lunedì con Geni Invisibili 3 dove parleremo di Italo Calvino e il sogno di ChatGPT, dell’invenzione dello sciopero (con Christian Greco e Marco Bentivogli), dei plantoidi (con Barbara Mazzolai e Carlo Ratti) ma anche del nostro curioso oblio su Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna (Gabriella Greison). In una storia spesso italiana. Massimo Sideri, inviato ed editorialista di scienza e tecnologia del Corriere della Sera, ha dedicato alle scoperte italiane dimenticate diversi libri, come La sindrome di Eustachio (Bompiani), L’innovatore rampante: l’ultima lezione di Italo Calvino e Il Visconte cibernetico: Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale, ambedue scritti con Andrea Prencipe (Lup). C’è un mondo da capire davanti a noi e con questo podcast l’autore vuole continuare a portarvi in un viaggio tra scienza e tecnologia incontrando i protagonisti di questa rivoluzione.
-
Per secoli il blu è stato il colore delle figure sacre, del velo della Madonna, della nobiltà dal sangue e dagli abiti blu, dei lapislazzuli. Fino a quando i genovesi nel Cinquecento non scoprirono nei loro viaggi in oriente l'indaco, una pianta che permetteva di ottenere la tintura giusta per gli abiti. Nacque così il Blu di Genova, una vera innovazione sociale che rese il blu accessibile a tutti. Ed è dalla storpiatura dei marinai inglesi del termine Blu di Genova che è nato il blue jeans. In questo episodio ne parlo con Renzo Rosso, il fondatore di Diesel che ha riportato la grandezza del blue jeans nella terra che gli ha dato il nome, passando dai miti di Levi's e di James Dean.
-
Chi ha rubato il taccuino di Charles Darwin con l'albero della vita da cui tutti siamo scesi? E perché? È il giallo con il miglior finale della storia, perché i taccuini B e C sono stati ritrovati nella Pasqua del 2022. Ma non per questo dando risposta a tutti i quesiti: perché quei taccuini sono attualissimi ora che l'Italia è diventata un posto a rischio per la biodiversità. Cosa sarebbe accaduto se, per ipotesi, Darwin avesse dovuto fare il suo viaggio oggi? Avrebbe potuto ancora tratteggiare la sua teoria sull'origine delle specie? Ne ho parlato con David Quammen, uno dei divulgatori scientifici più importanti al mondo, autore tra l'altro di Spillover (Adelphi). E con Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr che ha ora, tra le sue missioni, quella di costruire qui in Italia un centro internazionale proprio per la biodiversità.
-
Data per finita mille volte, la bicicletta è entrata nella sua quarta giovinezza e ci sta aiutando, grazie alla tecnologia del bike-sharing, a ridisegnare la mobilità cittadina. Ma quando è nata? All’inizio dell’Ottocento, dopo che nel 1815 un vulcano in Indonesia, il Tambora, esplose oscurando i cieli europei e causando siccità e morte, anche dei cavalli. Fu così che mentre Mary Shelley scriveva Frankenstein in un clima gotico, il Conte Drais inventava la draisina, la bicicletta senza pedali. Di innovazione incrementale in innovazione incrementale si arrivò alla bicicletta moderna, fino a quando il grande Ernesto Colnago, come racconta in questo episodio, incontrò nel Dopoguerra Enzo Ferrari per cambiare di nuovo e per sempre la storia della bicicletta e dei giri d’Italia e di Francia.
-
Il suo genio è noto. Ciò che fece - oltre a scoprire la rottura dell’atomo di uranio - molto meno: è Enrico Fermi, il misterioso personaggio che durante la Seconda guerra mondiale si muoveva a Oak Ridge negli Usa sotto lo pseudonimo di “the farmer”, il contadino. Fermi comprese per primo che i computer avrebbero rivoluzionato la ricerca scientifica. Non è un caso che, sempre a Oak Ridge, ci sia oggi uno dei supercomputer più potenti al mondo. Nel dopoguerra Fermi consigliò questi investimenti, ma sappiamo come si dice: nemo profeta in patria. Oggi però stiamo recuperando e inseguendo la portata della sua visione. E anche in Italia stiamo investendo in super e quantum computer. Ne ho parlato con uno dei fisici più famosi in Italia, Roberto Cingolani, ex ministro della Transizione ecologica con il governo Draghi, direttore scientifico a lungo dell’Iit di Genova e ora amministratore delegato della più importante società tecnologica in Italia, Leonardo. Ecco come quella intuizione di Fermi oggi ci può aiutare a raggiungere la sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica ed occupazionale. Anche grazie alla fisica quantistica e al gatto di Schrödinger.
-
Tutti sanno che Galileo Galilei ha inventato il telescopio. Peccato che non sia vero: lo strumento esisteva già e veniva dall’Olanda. Ma è vero che fu Galilei a migliorarlo e ad usarlo per inseguire “un’idea pericolosa”, come fece anche con “un occhialino per vedere le cose minime” (copyright dello stesso Galilei), battezzato microscopio dal suo amico e accademico dei Lincei Giovanni Faber. Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo, nulla sarà più come prima. Ecco allora che dobbiamo partire da telescopio galileiano, le lenti e la luce, con lo scienziato Alberto Diaspro dell’Iit, per farci portare vicini alle origini dell’Universo con il Big bang, grazie alle immagini che ci sta trasmettendo il James Webb Space Telescope, lo strumento più complesso che l’umanità abbia mai costruito come ci spiega in questo episodio Rita Sambruna, co-direttrice della divisione di astrofisica del Goddard Space Flight Center della Nasa. La lunga storia di un’innovazione e un’idea italiana, che hanno cambiato la scienza e ciò che sappiamo della natura.
-
Come è nato il World Wide Web? E chi lo ha veramente regalato al mondo? Ecco la vera storia che possiamo ricostruire grazie ai documenti che ho ritrovato negli archivi del Cern e a una testimonianza d'eccezione: Fabiola Gianotti, la direttrice del più prestigioso centro di Fisica delle particelle che ricorda anche il contributo italiano alla scoperta del Bosone di Higgs, la particella di Dio. Il regalo del web al mondo - ricordato qui anche con un'intervista che io stesso ho avuto la possibilità di fare in passato a Tim Berners-Lee, il padre dell'ipertesto - è uno dei momenti più alti di quella che oggi chiamiamo Open Science, la scienza aperta che vede come protagonista anche Ilaria Capua. La scienziata si racconta a partire da quella difficile scelta fatta ai tempi dell'aviaria e che oltre 15 anni dopo ci ha aiutati a sconfiggere la pandemia del Sars-Cov2.
-
Li usiamo ogni giorno. E prima o poi li usiamo tutti. Sono gli occhiali, strumento che nella storia dell'umanità può essere paragonato all'arrivo di internet per l'impatto che ha avuto e l'innovazione sociale che ha rappresentato. Grazie ad essi abbiamo battuto la natura declinante dell'occhio che destina tutti, prima o poi, a calare nell'ombra della presbiopia. Ma gli occhiali - io stesso li sto usando ora mentre scrivo - sono stati molto di più: lo status symbol del dotto e della capacità di leggere per secoli, la metafora della cultura e della conoscenza, ma anche il disgraziato indizio usato da Pol Pot in Cambogia per sterminare gli insegnanti e i professori. Dove sono nati? La solita, verrebbe da dire, Venezia. Qui ci riporta il primo documento in cui si parla degli "oculi de vitro cum capsula" del Nome della Rosa di Umberto Eco. Ecco la loro incredibile storia in un dialogo con il grande architetto Michele De Lucchi e il sociologo della scienza Massimiano Bucchi.
-
Ebbene sì: anche la più importante invenzione culturale della storia, il libro, ha l’impronta del genio italiano. Il libro “tascabile”, dunque quello che consideriamo il libro moderno, è nato grazie ad Aldo Manuzio alla fine del Quattrocento a Venezia, dove si recava anche Erasmo da Rotterdam. Fu lo stesso Manuzio ad avere inventato l’italic, il carattere che solo in Italia si chiama corsivo. Come al solito siamo bizzarri, ma geniali. Le sue stampe, dette aldine, possono valere una piccola fortuna. Ma anche sulla stampa a caratteri mobili c’è un’altra storia dimenticata, un piccolo giallo da riscoprire, quello di Panfilo Castaldi, contemporaneo del Guttenberg. Del libro e dei suoi antenati, gli antichi e preziosi papiri egizi, ma anche della nascita della scrittura, parlo con Christian Greco, l’egittologo di fama internazionale direttore del Museo egizio di Torino. Ma anche con il filosofo Luciano Floridi che ci porterà dalla preistoria all’iperstoria fino a quella profezia che lo stesso Italo Calvino aveva fatto negli anni Sessanta: grazie alla cibernetica arriverà un software capace di scrivere libri. Oggi lo chiamiamo ChatGPT. Soppianterà Dante, lo stesso Calvino e le poesie di Andrea Zanzotto?
-
Chi sono i Geni Invisibili? Inventori, innovatori, grandi scienziati italiani che hanno cambiato la nostra vita come abbiamo scoperto con la prima serie di questo podcast che è stata scaricata e ascoltata oltre 130 mila volte. Abbiamo così testimoniato che sono italiani il microprocessore (Federico Faggin), la matita (i coniugi Bernacotti), le biotecnologie (Claudio Bordignon), il pianoforte e la dimostrazione dell’esistenza del vuoto (Bartolomeo Cristofori ed Evangelista Torricelli). Passato, presente e futuro del progresso. Ma non finisce qui perché il nostro viaggio continua tutti i martedì con Geni Invisibili 2: lo sapevate che anche il libro tascabile e il corsivo sono italiani? Gli occhiali, la chiocciola, il telescopio galileiano ma anche l’attuale rivoluzione dell’Open science, la scienza aperta, hanno le proprie radici nel nostro genio come in questo podcast ci riconosce anche Steve Wozniak, il padre dell’Apple I. Creatività: ecco cosa ne abbiamo fatto. In una storia tutta italiana. Massimo Sideri, inviato ed editorialista di scienza e tecnologia del Corriere della Sera, ha dedicato alle scoperte italiane dimenticate diversi libri, come La sindrome di Eustachio (Bompiani) e L’innovatore rampante: l’ultima lezione di Italo Calvino scritto con Andrea Prencipe (Lup). C’è un mondo da capire davanti a noi e con questo podcast l’autore vuole continuare a portarvi in un viaggio tra scienza e tecnologia incontrando i protagonisti di questa rivoluzione.
-
Chi ha inventato il pianoforte? Già il nome contiene il primo indizio, perché dal Settecento è cambiato solo l’ordine delle parole: si chiamava fortepiano e anche nel dizionario inglese si è ristretto di poco, diventando "The Piano". Se per qualche tempo il giallo ha avuto un suo seguito, da almeno due secoli è certo che il principe degli strumenti, capace di sottomettere un’orchestra intera, è un’invenzione italiana. Fu Bartolomeo Cristofori, nato a Padova il 4 maggio del 1655, cembalaro anche alla corte di Ferdinando de’ Medici, a inventare un «Arpicimbalo di nuova inventione, che fà il piano e il forte» come si legge negli archivi medicei dell’inizio del Settecento.
E se il violino non può vantare un padre certo (fece la sua comparsa nel XVI secolo in vari punti dell'Europa, tra cui certamente Cremona), possiamo sicuramente dire che i più grandi liutai sono stati italiani, come Stradivari, Guarnieri, ma anche Gagliano, come racconta il maestro Alessandro Quarta in questo episodio, in cui suona proprio un Gagliano del 1723.
Gli altri protagonisti della puntata sono il pianista Jazz Giuseppe Magagnino e il rettore della Luiss, Andrea Prencipe, con cui Massimo Sideri riflette sulla tensione calviniana tra piano e forte partendo dal nostro libro su Italo Calvino e l'innovazione. -
È un vero e proprio attentato alla gravità di Newton. Senza la rotazione delle pale verrebbe giù come un sasso, senza planare. Ma chi ne ha intuito il concetto? L'idea è racchiusa nella vite rotante di Leonardo Da Vinci che si trova nel codice Atlantico, ma ci sono voluti 500 anni per realizzarlo. Anche grazie al prototipo costruito dal nostro genio invisibile Enrico Forlanini: un "elicottero" con due eliche controrotanti azionate da un motore a vapore che prese il volo a Milano nel 1877, considerato il primo mezzo motorizzato più pesante dell'aria ad alzarsi in volo.
Oggi è possibile ammirare l'originale di Forlanini al Museo di Scienza e tecnologia di Milano come mi racconta nel podcast il direttore Fiorenzo Galli. Mentre gli elicotteri moderni sono sempre di più progettati grazie ai super computer. Così Carlo Cavazzoni, di Leonardo, ci porta dentro il futuro della tecnologia del volo. Come diceva Albert Einstein, tutti sanno che una cosa non si può fare fino a quando arriva un ingenuo che non lo sa e la fa. -
L’intelligenza artificiale e la robotica hanno storie molto diverse tra loro. La prima è nata con Alan Turing nel 1950, è collegata ai computer e oggi si presenta nelle nostre case con le vesti di un algoritmo di machine learning con cui possiamo dialogare, come ChatGPT. I robot hanno invece radici molto profonde che risalgono nella storia fino a Leonardo da Vinci e addirittura a uno dei saggi della chiesa, Alberto Magno, protettore degli scienziati. Compaiono già nei trittici di Hieronymus Bosch a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento. Ma oggi quali sono gli interrogativi che dobbiamo porci? Possiamo considerare l’AI come il “cervello” del “corpo” robot? Dobbiamo averne timore oppure sono una risorsa per l’umanità? A livello scientifico qual è lo stato dell’arte?
Per capirlo parliamo con due tra i maggiori esperti di questi argomenti, la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, e il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Giorgio Metta. -
Le terapie geniche hanno curato alcune malattie rare e ora promettono di poter agire sulla più grande "pandemia" al mondo: quella dei tumori. Ma dove sono nate? Anche se sono in pochi a saperlo, l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale, con lo scienziato Claudio Bordignon che nel '92 concluse il primo esperimento sulle cellule staminali del sangue umano. Ecco le biotecnologie nel racconto di Bordignon e di Pierluigi Paracchi, cofounder della biotech Genenta quotata al Nasdaq.
-
Stiamo cercando tracce di vita biologica su Marte. Non è un caso che il Rover che manderemo sul Pianeta rosso nel 2028 si chiamerà Rosalind Franklin, il nome della scienziata che con le sue fotografie avviò il percorso che avrebbe portato alla scoperta della doppia elica del DNA. Ma furono altre immagini della fine dell'Ottocento a far nascere lo stesso mito dei marziani: quelle nate dalle osservazioni dell’astronomo italiano, Giovanni Schiaparelli, fatte dall'Osservatorio di Brera, proprio a pochi passi dal Corriere della Sera, a Milano. Non è un caso che nel linguaggio comune e cinematografico parliamo proprio di marziani e non, per esempio, di saturniani.
In questa puntata raccontiamo la potenza che questo mito ha avuto sullo sviluppo della scienza e della tecnologia con Valentina Sumini, space architect dell'Mit di Boston, e con Fiorenzo Galli, direttore del Museo di Scienza e Tecnologia di Milano che custodisce uno dei telescopi proprio di Schiaparelli. -
Lo sapevate che senza il vuoto non avremmo avuto buona parte della tecnologia moderna?Prendete una lampadina: senza il vuoto al suo interno non funzionerebbe. Senza il vuoto non avremmo avuto la tv a tubi catodici e sempre senza il vuoto non avremmo potuto eseguire tutti gli esperimenti scientifici al Cern di Ginevra che hanno portato alla scoperta del bosone di Higgs, la particella di Dio. E chi ha dimostrato l'esistenza del vuoto, negata da Aristotele? Non Blaise Pascal, come si legge ancora in tanti libri, ma uno sfortunato allievo di Galileo Galilei, Evangelista Torricelli.
Oggi senza il vuoto e la tecnologia non potremmo dunque avere nemmeno le smart cities, nate anche da un'intuizione di un grande architetto italiano, Carlo Ratti, che ci racconta come nel prestigioso Mit di Boston ha fondato il Senseable City Lab, il laboratorio della città con i sensi. - Show more